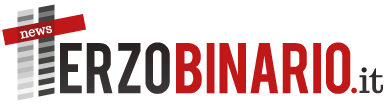La domanda è d’obbligo: perché scegliere questo titolo, che per di più molto probabilmente godrà di una distribuzione limitatissima se non pressoché nulla, per inaugurare la mia collaborazione con Terzo Binario? Me lo sono chiesto anch’io, cercando di dimenticare il pressante desiderio di parlare del film a tutto il mondo, dopo la visione al Filmaker Festival di Milano.
E la risposta che ho trovato, fondamentale anche per la definizione degli obiettivi che si pone questo spazio, è la seguente: perché Leviathan parla del nostro mondo senza che in esso vi sia alcun messaggio verbale, riuscendo a illuminare un frammento di realtà attraverso un discorso puramente audio-visivo.
L’opera dei due registi Lucien Castaing-Taylor e Verena Paravel, distintisi in precedenza per altre pellicole a carattere etnografico, è nata con lo scopo di documentare l’attività della pesca commerciale nell’Oceano Atlantico, divenendo poi in itinere una riflessione sull’azione dell’uomo e il suo rapporto con una natura impenetrabile, oscura e misteriosa.
Imprescindibile la dimensione tecnologica dell’operazione: i due infatti, resosi conto dei problemi legati alla ripresa su una nave in constante movimento, hanno deciso di dotarsi di una decina di telecamerine leggerissime, di quelle usate dai surfisti per riprendere le proprie esibizioni. Ciò da una parte implica una mobilità straordinaria (vengono infatti gettate a picco nel mare, abbandonate libere in mezzo al pescato, passate di mano dai marinai agli operatori), dall’altra annulla completamente la distanza tra spettatore e oggetto sullo schermo, creando un’esperienza di forza emotiva unica, sconvolgente e insieme raggelante.
Le immagini infatti sfiorano quasi l’illeggibilità, sopratutto nella prima parte, mentre si è immersi nelle tenebre quasi totali e si osservano i due mostri, la nave e l’oceano, scontrarsi e lottare, assorbiti e frastornati dal clangore del metallo e dal potente sciabordio delle onde. Ma non è la confusione il sentimento che prende al cuore e allo stomaco, quanto il disgusto e insieme la fascinazione, congiunti inspiegabilmente durante le sequenze in cui vediamo i marinai scaricare il loro carico guizzante, ancora palpitante ma ormai prossimo alla morte, e martoriarlo in un serie di gesti meccanici reiterati all’infinito. Carne squarciata, tagli netti vibrati con automatica ferocia, corazze fracassate, corpi gettati da parte, in attesa che ritornino, senza vita, all’elemento da cui provengono: è la normalità di un massacro quotidiano, un bagno di sangue giornaliero sul ponte della nave.
E nuovamente ci immergiamo nel mare, assistiamo inermi ai suoi turbamenti, agli sconquassi delle acque, cullati e scaraventati dai flutti poderosi, e partecipiamo alla danza delle stelle marine, quasi risvegliata da un sogno atavico dal pigro movimento della nave.
Unico sollievo a questo  suggestivo e affascinante viaggio nell’incubo è la visione del volo dei gabbiani, che accompagnano i pescatori nel loro pellegrinaggio liquido. Sembrerebbe un segno di pace e di serenità, se non ci pungolasse la consapevolezza che la loro presenza è dettata unicamente dalla possibilità di cibarsi degli scarti prodotti dalla violenza descritta poc’anzi…
suggestivo e affascinante viaggio nell’incubo è la visione del volo dei gabbiani, che accompagnano i pescatori nel loro pellegrinaggio liquido. Sembrerebbe un segno di pace e di serenità, se non ci pungolasse la consapevolezza che la loro presenza è dettata unicamente dalla possibilità di cibarsi degli scarti prodotti dalla violenza descritta poc’anzi…
Dopo i titoli di coda, in cui tutti gli animali vengono ringraziati (attraverso il nome scientifico di ogni specie), si ritorna col pensiero al titolo del film: il Leviatano del titolo è il mostro marino citato nel Levitico, simbolo dell’incommensurabile potenza divina e della supremazia della natura sull’uomo, o è il corpo sociale di Hobbes, l’unico mezzo individuato dal filosofo per scampare all’homo homini lupus (a quanto sembra, però, ai danni di creature inermi)?