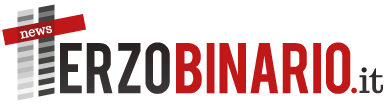Circa tre anni fa mi abbonai per la prima volta alla rivista Orizzonti, edita dall’Aletti editore.
Allegati alla rivista ci sono di solito due libri di poesie o racconti.
Nella prima che mi arrivò a casa, c’era un libro di poesie di un certo Giuseppe Cappello dal titolo.
IL CANTO DEL TEMPO. Mi piacquero subito quelle poesie per la loro intensità, espressa in pochi e concisi versi.
Leggo negli accenni biografici di questo Giuseppe Cappello, che lavora come insegnante presso un liceo. Sul retro della copertina del libro c’è il riferimento al blog e per curiosità lo vado a visitare.
Non so se voi lo sapete ma io lavoro presso la segreteria del liceo Pertini di Ladispoli.
Come mi si apre il blog vedo la fotografia di Giuseppe e mi prende un colpo, non era possibile, era un insegnante supplente annuale di Filosofia, che quell’anno stava in servizio da noi!
Non ci potevo credere, Giuseppe, quel simpaticone e buontempone, sempre con la battuta romana sulle labbra, uno spasso. Figuratevi lo stupore di scoprire quale poeta si nascondeva dietro quel faccione bonario e semplice.
Cappello ha un verseggiare filosofico, non già per la complessità dei vocaboli, ma per come sono composte le parole il suono, i colori, i profumi, i continui richiami alla Grecia arcaica e alla sua filosofia, che tanto si intesse con la nostra vita. Caratteristica dei libri di Cappello è il testo inglese posto a volte a fronte di quello italiano e a volte in calce al libro. Questo utilizzo della lingua inglese rende il verso internazionale. Sembra quasi che Cappello faccia uscire la poesia italiana dalle pastoie retoriche.
Per saggiare questo poeta vi riporto l’incipit della poesia IN CHIAVE DI ORO della raccolta IL CANTO DEL TEMPO: “L’arpeggio tesse un ordito logaritmico … sentite che suono tra”.
“Ordito” e “ logaritmico” questa figura retorica si chiama paranomasia o consonanza e cioè l’utilizzo di consonanti affini anche per suono o eufonia. Il richiamo alla matematica, tutti i versi di Giuseppe hanno qualcosa di matematico, sappiamo infatti quanto la filosofia, soprattutto quella greca, molto si interseca allo studio della teoria della matematica. Al contempo quell’arpeggio, verbo/soggetto ci evoca un suono dolce e melodioso, ci addolcisce il logaritmo della vita. Tutta la raccolta verte sul tema del tempo, ma senza i lamenti tipici dei poeti. Cappello scandaglia il tempo, seguendo il percorso logico del suo pensiero filosofico, che rende unica la sua poesia.
Altra raccolta di pregiati versi di Giuseppe è IL GIOCO DEL COSMO sempre edito da Aletti. E’ da notare che anche qui nel titolo si continua a parlare di immensità, quale è la nostra vita quotidiana. Immensa nel suo rigirare di pensieri, di storture e di grandi amori. Analizza con la delicatezza di una ricamatrice, il nostro poeta, i sentimenti e le emozioni, ma è meglio che lasciamo parlare i suoi versi.
Tratto da L’ACCENTO BARBARO DEL LOGOS, una delle poesie della raccolta:
“… Cade barbaro l’accento sulle ore dello studio
sui giorni interi
di un’adolescenza già in cerca del bandolo del tempo
le domande della filosofia non hanno una risposta
quale filosofia a rispondergli
in un angusto spazio devo scrivere l’insufficienza…….. “
non posso riportarla tutta ma vi assicuro che è un crescendo di forti emozioni. Si vede l’occhio del docente su quell’umanità adolescenziale in fermento, la quale si può solo amare come la vita, senza se e senza ma. Si vede un docente e cioè un adulto che si interroga sul suo ruolo educativo, sull’effetto positivo nella vita di ciò che si studia.
La scuola per Giuseppe è il luogo di maggiore ispirazione. Ama il suo mestiere e lo stato lo ripaga con una perenne precarietà ma lui è tenace, solare, sufficientemente incazzato da sbatacchiare i suoi poderosi pugni su questa palude morale di questa nostra nazione.
Appunto “ Scuola “ si intitola l’ultima raccolta ed è stata concepita durante l’anno che Giuseppe ha trascorso al Pertini. Numerosi sono i riferimenti al treno, al mare e di rimando alla sua bambina, deliziosa ed amata, gioia dei suoi occhi e motivo del suo lottare. Sempre presente la filosofia e la mitologia greca e la Grecia tutta. Suo è anche un libro dal titolo Viaggio in Grecia in cui attraverso le foto, da lui scattate, descrive luoghi, aneddoti e soprattutto cenni dell’antica filosofia greca.
Vi lascio con questi versi della poesia tratta da Scuola, in cui è forte la descrizione della fatica dell’insegnare per accendere “ l’iride dei ragazzi “ e il docente suda e il suo sudore è filosofico, una metafora che serve a spiegare meglio il concetto del “ docère “ di latina memoria.
LA FENICE DI MINERVA
Lemma su lemma si scioglie la lezione
un sudore filosofico sulla mia pelle
nell’iride dei ragazzi lo specchio della secrezione
intorno alla parola un entusiasmo dermoeidetico
celeste corrispondenza sulle ceneri delle menti
fra i cipressi che da Mileto vanno a Tubinga
sul far del giorno si leva la fenice di Minerva.