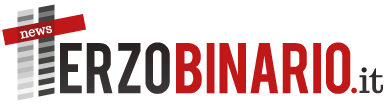Non chiamatela crisi per favore. La depressione dell’economia europea e italiana in particolare è diventata cronica, trasformando la crisi in una condizione duratura a cui dovremo abituarci presto, se non l’abbiamo ancora fatto. È il tenore di vita che si abbassato, portando con sé un quadro di aspettative al ribasso che in psicologia prenderebbe il nome di rassegnazione. Ma anche inducendo la popolazione a cambiare il proprio stile di vita, con conseguenze non sempre negative.
Non chiamatela crisi per favore. La depressione dell’economia europea e italiana in particolare è diventata cronica, trasformando la crisi in una condizione duratura a cui dovremo abituarci presto, se non l’abbiamo ancora fatto. È il tenore di vita che si abbassato, portando con sé un quadro di aspettative al ribasso che in psicologia prenderebbe il nome di rassegnazione. Ma anche inducendo la popolazione a cambiare il proprio stile di vita, con conseguenze non sempre negative.
Nel Paese con il più alto numero di veicoli pro capite, le immatricolazioni delle automobili sono dimezzate negli ultimi cinque anni e nel 2012 il numero delle patenti rilasciate è sceso del 19,3 per cento rispetto all’anno prima. A Roma – chi l’avrebbe mai detto – il parco auto circolante è diminuito di 70mila unità, nonostante l’aumento della popolazione. I campeggi non sono mai stati così pieni e le aree per i camper crescono come funghi, anche nel nostro territorio. Proliferano bed & breakfast e affittacamare a danno degli hotel. I proprietari delle case hanno rivisto al ribasso gli affitti per gli studenti fuori sede, mentre le università per la prima volta dal dopoguerra registrano un calo consistente di iscrizioni. Diminuiscono i menu al ristorante, mentre un numero sempre maggiore di stabilimenti balneari permette di portare il pranzo al sacco. L’acqua – meno male – la si prende dalle fontanelle o dal rubinetto e via discorrendo.
Insomma cambiano le condizioni economiche e cambiano i costumi, spesso positivamente, ma al tempo stesso si erodono i diritti fondamentali acquisiti nei decenni passati. Primo fra tutti il diritto al lavoro. E per creare lavoro serve la crescita, obiettivo che finora la politica non è riuscita a centrare.
È evidente che, nonostante i ripetuti annunci di spiragli e luci miracolose al di fuori del tunnel, le ricette “salvifiche” del rigore, del mantenimento a un livello bassissimo dei tassi di interesse della Bce, delle privatizzazioni e persino dei tagli ai costi della macchina statale – tra cui i famosi tagli ai costi della politica – sono serviti a ben poco. Il debito anzi è aumentato: a maggio ha registrato un incremento di 33,4 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo “un nuovo massimo storico”, a 2.074,7 miliardi. Nonostante l’aumento delle entrate tributarie.
Se la soluzione prospettata alla Grecia per uscire dalla crisi significa tagliare posti di lavoro nella pubblica amministrazione – l’ultima sforbiciata ne ha fatti fuori 25mila-, chiudere la tv pubblica senza colpo ferire e con essa un pezzo di libera informazione e cultura – come dimenticare le lacrime dell’orchestra sinfonica dopo 75 anni di gloriosi successi – forse siamo davvero a un passo dalla morte dello Stato sociale e, chissà, dello Stato moderno in sé, come entità politica sovrana e rappresentativa del corpo elettorale. Un pensiero va anche alla nuova forma di Repubblica presidenziale de facto in Italia che ha dato vita, seppur con tutte le circostanze del caso, agli ultimi due governi italiani, mai così lontani dalla volontà popolare.
 Negli anni Trenta il presidente Franklin Delano Roosevelt, facendo proprie le teorie keynesiane, riuscì a risollevare un Paese dalle melme profonde della più grande crisi contemporanea, creando 2 milioni di posti di lavoro l’anno grazie a un vasto intervento dello Stato nell’economia e a un piano di rilancio delle opere pubbliche.
Negli anni Trenta il presidente Franklin Delano Roosevelt, facendo proprie le teorie keynesiane, riuscì a risollevare un Paese dalle melme profonde della più grande crisi contemporanea, creando 2 milioni di posti di lavoro l’anno grazie a un vasto intervento dello Stato nell’economia e a un piano di rilancio delle opere pubbliche.
A cinque anni dall’inizio della crisi economica ancora non si vede una via d’uscita. Le previsioni del Pil per il 2013 per l’Italia segnano un -1,9%, e potrebbero essere riviste ancora al ribasso. I dati sull’occupazione mostrano un tasso cresciuto mediamente di 0,2 punti percentuali rispetto ai primi due mesi dell’anno, raggiungendo in maggio il 12,2 per cento, e la possibilità di sfiorare il 13 per cento nel corso del prossimo biennio. Mentre il numero di occupati diminuirebbe di circa l’1,5 per cento.
Nel primo trimestre del 2013 i consumi privati sono diminuiti dello 0,5 per cento rispetto al quarto del 2012 (oltre -1 per cento, in media, nei sei trimestri precedenti). Per incentivarli occorrono più soldi in tasca ai consumatori medi, magari detassando le tredicesime, aumentando i salari e tagliando le tasse sul lavoro in busta paga – il taglio del cuneo fiscale fu fatto da Prodi ma solo per la parte a carico delle imprese. Eppure la risposta del nostro governo va nella direzione opposta, con la decisione di introdurre un ulteriore aumento dell’IVA. In nome del rigore appunto. Nessuna ipotesi di patrimoniale, per far pagare i più ricchi e redistribuire la ricchezza, è stata invece presa in considerazione. Si tratta di un tabù in un governo Pd-Pdl. La logica è semplice: 300 euro in più nella busta paga di un impiegato verrebbero subito spesi e immessi nel mercato facendo riprendere i consumi e evitando conflitti sociali, mentre 3000 euro in meno alle fasce di alto reddito non cambierebbero affatto il loro tenore e farebbero aumentare le entrate per lo Stato.
Se le ricette del FMI e della BCE vengono vendute come le uniche possibili, rimandando di anno in anno l’arrivo dei risultati, dall’altra parte del mondo c’è chi ha deciso di intraprendere una strada radicalmente opposta.
 Con la vittoria di Shinzo Abe alle elezioni dello scorso dicembre , il Giappone ha intrapreso una politica agli antipodi del rigore, ribattezzata Abenomics. Il nuovo governo del Paese, che ha un debito pubblico altissimo ma totalmente nelle mani degli stessi cittadini giapponesi, ha deciso di stampare moneta in abbondanza, facendo abbassare il valore dello yen in modo da attirare un grande flusso di investitori stranieri e far ripartire l’export, minacciato dal gigante cinese.
Con la vittoria di Shinzo Abe alle elezioni dello scorso dicembre , il Giappone ha intrapreso una politica agli antipodi del rigore, ribattezzata Abenomics. Il nuovo governo del Paese, che ha un debito pubblico altissimo ma totalmente nelle mani degli stessi cittadini giapponesi, ha deciso di stampare moneta in abbondanza, facendo abbassare il valore dello yen in modo da attirare un grande flusso di investitori stranieri e far ripartire l’export, minacciato dal gigante cinese.
La politica espansiva prevede un aumento mirato dell’inflazione – che dovrebbe raggiungere e mantenere la soglia del 2%. Va da sé che una simile strategia porti a una perdita del potere d’acquisto dei salari, almeno in un primo momento, e a un aumento della spesa pubblica (previsto di 1,5%), ma nel complesso i risultati positivi sull’economia reale sembrano di gran lunga maggiori. Alle misure adottate in campo economico hanno fatto seguito significative riforme strutturali. Le tre frecce, come le ha nominate il governo di Tokyo. Alla prima fase di politica monetaria espansiva si è succeduta una nuova serie di interventi di politica fiscale, con un aumento dei salari e dei premi di produzione nel pubblico e nel privato. La terza freccia, appena scagliata, intende aumentare la competitività e garantire una crescita nel medio e lungo termine. La riforma prevede misure come un aumento del 10% degli investimenti nei prossimi tre anni, la vendita online di medicinali, la creazione di zone economiche speciali destinate ad attrarre investimenti dal Giappone e dall’estero e una forte espansione degli investimenti nel settore delle infrastrutture.
I risultati non si sono fatti attendere. Nel primo quadrimestre del 2013 il tasso di crescita annuale del Giappone si è attestato attorno al 3,5% mentre il mercato della Borsa è cresciuto del 55%. Dopo oltre un decennio di depressione economica, il Giappone sembra aver ripreso le redini dell’economia globale ritornando un attore competitivo nello scenario internazionale e reagendo alla sfida dei mercati vicini, dominati dalla Cina e dalle tigri asiatiche (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud). Non sappiamo quanto durerà. Finora però il governo Abe sembra godere del consenso più ampio che un premier giapponese degli ultimi decenni ricordi ed è quasi scontato che le elezioni per il rinnovo della Camera Alta, che si svolgeranno oggi, gli consegneranno un’ampia maggioranza.
È un modello difficile da ripetere tout court dalle nostre parti, ma è la dimostrazione che la strada del rigore assoluto e delle ricette di tagli e privatizzazioni non è l’unica possibile, come ci è stato venduto quotidianamente sui tg e nei talk show degli ultimi cinque anni.
La crisi appunto non è più tale perché sarà impossibile ritornare ai vecchi livelli di produzione e occupazione, ma proprio su quest’ultimo fronte occorre trovare un’altra strada se quella vecchia non ha funzionato. Il rischio è che non regga la tenuta sociale, con conseguenze imprevedibili. E non c’è da stare tanto tranquilli se, come ricorda il premio Nobel Paul Krugman, “l’ultima volta che ci siamo trovati in una situazione del genere fu prima della Seconda Guerra Mondiale”.