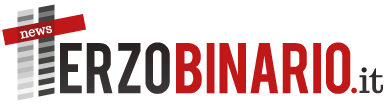“Perché viaggiare non è solamente partire, partire e tornare, ma imparare le lingue degli altri, imparare ad amare” (Francesco De Gregori)
La questione identitaria per un migrante di prima generazione, anche se viene contemplata prima di emigrare, diventa prioritaria e significativa soltanto nel momento in cui si fa ritorno nel Paese di origine e si realizza il cambiamento avvenuto. Cioè quando ci si rende conto che non si viene più percepiti come cittadini di quel posto e non si ha neanche più lo stesso senso di appartenenza a quella realtà oppure quando si incomincia a pensare e sognare nella lingua di adozione ecc.
Ancora più problematica è la condizione dei migranti di seconda generazione che nascono in un Paese come l’Italia, dove vige lo Ius sanguinis, il diritto di cittadinanza solo per i discendenti dei cittadini italiani. Per molti potrebbero sembrare questioni lontane, che non li riguardano, invece ci sono persone che vivono vicino a noi, nella stessa città, che hanno tante cose interessanti da raccontare, che potrebbero darci tanti spunti di riflessione su problematiche universali che riguardano tutti noi e che ci possono arricchire.
Una di queste persone vive a Ladispoli da circa 6 anni. Si chiama Sandra Bossio Risso e la sua biografia è impressionante: nonni italiani e genitori peruviani, cresciuta in Francia e in Messico, doppia cittadinanza (italiana e peruviana), poliglotta (madre lingua spagnola e francese, parla l’italiano e l’inglese). Ha lavorato come assistente universitaria alla Facoltà di Scienze dell’educazione a Ginevra ed ha avuto un’esperienza come insegnante di spagnolo in Francia, ma la voglia di conoscere le sue radici l’ha portata in Perù nel periodo di transizione che seguì l’esilio del Presidente Fujimori. Lì ha lavorato come consulente esterno del Ministero dell’educazione in un progetto che riguardava l’accreditamento delle scuole post-liceali sul modello già esistente in altri Paesi dell’America Latina. Nonostante si trovasse bene nel Paese di origine dei suoi genitori e avesse delle prospettive lavorative promettenti, è tornata in Svizzera dove l’aspettava quello che sarebbe diventato suo marito, conosciuto proprio una settimana prima delle sua partenza “per il lungo viaggio” : “In Perù avrei avuto una carriera e uno stipendio tre volte superiore a quello che percepisco attualmente, ma non ho rimpianti. Sono felice con mio marito e dove sta lui, vado anche io”.
Dopo circa un anno dal suo ritorno si sposarono, però costruire un futuro in Svizzera non era facile. Nonostante fosse cittadina italiana e abitasse in una località francese a pochi chilometri dal confine svizzero, aveva comunque bisogno di un permesso di soggiorno. La richiesta venne respinta: “Un italiano per gli svizzeri è più o meno come un marocchino in Italia, non li possono vedere. Non hai nessun diritto, non sei nessuno”. Gli dissero che poteva continuare a fare da “pendolare”, ma non era il tipo di vita che desiderava. La situazione burocratica non era migliore neanche per suo marito, un ruandese venuto in Europa per studiare. La sua richiesta di asilo politico in Svizzera venne respinta. Decisero di riemigrare e la scelta ricadde sull’Italia. Gli elementi che stanno alla base della loro decisione sono diversi.
Consapevoli che la situazione in Italia non sarebbe stata facile, ritenettero migliori le politiche italiane sulla migrazione rispetto a quelle svizzere. Inoltre, in Italia, almeno lei si sarebbe trovata in una situazione burocratica nettamente favorevole, in quanto “oriunda” italiana. Quindi, dieci anni fa sono arrivati in Italia e si sono stabiliti inizialmente a Bergamo dove viveva un suo zio peruviano, ma dopo circa 3 anni hanno deciso di spostarsi a Roma perché aveva trovato un lavoro “vero, con la busta paga”, mentre a Bergamo solo suo marito era riuscito a trovare un lavoro fisso in un albergo, dove lavora ancora adesso. Considerando il costo alto degli affitti a Roma, ha cercato casa in Provincia e così è arrivata a Marina di Cerveteri, consigliata da un amico italo argentino: “Ladispoli era più vicina e più popolata, ma da Cerenova avrei avuto più possibilità di trovare posto a sedere sul treno, un vero lusso per i pendolari ladispolani”. Sottovalutando il consiglio dell’amico, ha scelto invece Ladispoli , città della quale si è innamorata a prima vista soprattutto per la sua vicinanza al mare.
“ Non ho parecchie identità, ne ho una sola, fatta di tutti gli elementi che l’hanno plasmata, secondo un <dosaggio> particolare che non è mai lo stesso da una persona all’altra.”( Amin Maalouf)
Sandra, considerando che sei vissuta in più Paesi e le tue origini sono multiple, mi piacerebbe parlare con te della questione “identità”. Tu come ti definisci?
Cerco di conciliare le mie “multiple identità”, valutando la risposta in base all’interlocutore. Mi sono sentita straniera ovunque, ero straniera in Francia, in Messico, in Svizzera, quando vado in Perù sono straniera. Quando parlo con un peruviano dico di essere peruviana perché sono una peruviana nata all’estero, sono una seconda generazione per i peruviani. Sono italiana perché i miei nonni erano italiani e quindi sono la terza generazione di italiani all’estero. Normalmente mi definisco italo-peruviana.
Sei cresciuta e hai studiato in Francia, ti senti anche francese?
Sono cresciuta in Francia “come straniera” per più di 20 anni, non ha mai ottenuto la cittadinanza francese ma non è per questo motivo che non sento di appartenervi. Sentirsi di un posto non dipende dalla cittadinanza. I miei legami affettivi con la Francia sono forti anche attualmente visto che la mia famiglia di appartenenza vive lì. Senza dubbio sono legata culturalmente alla Francia, mi sento e sono anche “francofona”.
Questo nonostante in Francia il modello d’integrazione fosse “l’assimilazionismo” (considerare tutti come cittadini francesi, le differenze non contano e di conseguenza i diritti e gli obblighi sono uguali per tutti)?
Sono andata a scuola pubblica laica, senza simboli religiosi dove tutti sono trattati nella stessa maniera. C’è la libertà religiosa, ma a scuola tu sei “fille de la République”. I miei compagni di scuola erano di origini molto diverse, visto che eravamo molto vicini a Ginevra dove ci sono gli organismi internazionali ed europei. Ma questo non mi ha impedito di essere peruviana, di mantenere le mie tradizioni, come la lingua spagnola parlata in famiglia.
Tu vivi in Italia da circa 10 anni, sei cittadina italiana dall’età di 18 anni in quanto discendente di italiani. Ti senti italiana?
Con l’Italia il rapporto è stato sempre diverso rispetto alla Francia. Mi sono sempre sentita legata affettivamente, come se le mie radici fossero più forti della cultura con la quale sono cresciuta anche se gli italiani mi vedono come una “straniera”. La stessa cosa succede in Perù dove mi sento a casa mia, nonostante non sia vissuta per tanto tempo.
Per quanto riguarda Ladispoli, ti percepisci parte di questa città?
Credo che dipenda anche dall’età, visto che col passare del tempo mi sono stancata di essere sempre una straniera ovunque vada. Sono vissuta con questa catena al piede, con l’idea sempre presente di non essere di nessun posto. Attualmente ho deciso che sono solo di Ladispoli, sono italiana anche se non so per quanto tempo rimarremo qui. Ma nello stesso tempo mi sento anche peruviana.